La simbologia proto-romanica nell'arte longobarda
Il cuore della Toscana ci racconta di tesori di grande valore artistico che tramandano antichissimi culti ancestrali delle prime popolazioni autoctone europee sopravvissute all'ultima grande glaciazione. Le Pievi della Toscana rappresentano un forte senso di continuità col passato.
Facciamo qui una selezione dei principali temi che costituiscono un marker stilistico della presenza longobarda in Toscana, in modo che sia possibile per tutti avere la chiave di lettura per leggere queste antiche testimonianze.
Il vortex.
Il vortex è un simbolo molto antico sviluppatosi in molte civiltà indoeuropee, è centrale nella simbologia caucasica nel motivo iconografico della cosiddetta ruota armena dell'eternità. Simbolo solare per eccellenza rappresenta la forza generatrice della natura, ed il principio primo della vita.
Il vortex, la cui genesi è parallela a quella della svastica, un antichissimo simbolo di buon auspicio (sanscrito suasti-ka, portafortuna), è uno simboli della prima chiesa che vede l'Armenia come uno dei suoi centri propulsori a partire dal IV secolo. E' possibile che questa lastra conservata nell'antica Pieve di San Leolino presso Panzano in Chianti sia una testimonianza delle dottrine dell'arianesimo che venute da oriente ebbero un particolare successo tra i barbari convertiti tra cui Goti e Longobardi. In queste dottrine Dio è visto come principio generatore distinto dal Figlio che concepito dal divino ha però una sua natura umana. In pratica viene negata la trinità e la consustanzialità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'arianesimo, che prende il nome dal teologo Ario (256-336), fu condannato come eresia dal Concilio di Nicea nel 325.
Troviamo il motivo del vortex in alcune lastre in arenaria ad ornato depresso che nei templi proto-romanici costituivano il parapetto e quindi la divisione fisica tra il celebrante e la comunità dei fedeli. Queste lastre sono nella Pieve di San Leolino a Panzano nel Chianti fiorentino, una funge da supporto per l'altare, l'altra fa da decoro per il léggìo. La croce nella lastra inscrive un motivo celtico tipicamente nordico dell'arte vichinga che è il Nodo di San Giovanni. La lastra sotto l'altare è montata al contrario e quindi per poterla vedere correttamente occorre ruotare l'immagine di 180 gradi.
In questa lastra è evidente come l'arte longobarda, ma è possibile che la lastra sia anche di origine gotica, sia caratterizzata da uno stretto legame tra i simboli cristiani, in questo caso la croce, e le forze che regolano la natura, retaggio delle antiche credenze delle tribù germaniche. In particolare si noti la similitudine dei vortex con l'immagine su una pietra scolpita risalente all'età del ferro nordica e proveniente dall'isola di Gotland in Svezia.
Altri interessanti frammenti di questo tipo di lastre si trovano sul pluteo della Pieve di Corsignano a Pienza nel senese.
Il Nodo di San Giovanni (St. Hans Cross)
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente un simbolo ricorrente in tutte le architetture altomedievali di origine longobarda è il nodo di San Giovanni, San Giovanni fu oggetto di un partcolare culto da parte dei Longobardi in quanto rappresentava la ciclicità della vita che si identificava nel rito del battesimo. Si tratta di un antico simbolo magico protettivo scandinavo che ritroviamo anche in epoca vichinga ma che ha la sua origine in epoche assai più remote come nell'età del bronzo nordica. Il simbolo è utilizzato anche nel misticismo della Cabala.
Curiosamenente il nodo di San Giovanni detto anche St Hans's cross o St. John's Arms è il simbolo che Steve Jobs inserì nella tastiera del mac per identificare il command key e corrisponde al codice Unicode U+2318 ⌘
La stella a sei punte.
Altro simbolo assai ricorrente nell'iconografia longobarda è la stella a sei punte, detto anche "fiore della vita" o "stella-fiore", si tratta di una simbologia legata al culto del sole diffusa tra i paesi nordici ma anche in altre culture, panceltico e probabilmente legato ad un origine indoeuropea o indoaria. Le prime attestazioni di questo simbolo sono in ambito assiro e fenicio. Il fiore della vita, chiamato anche Sole delle Alpi e rosa celtica, si ritrova anche nel logo della Lega e della Padania.
La sirena bicaudata.
Questa raffigurazione evoca culti legati alla fertilità e ci riporta alla leggenda della Melusina (vedi post) ed al culto di Nerthus maturato soprattutto in ambito scandinavo e germanico. Secondo Tacito. I Longobardi condividevano il culto di Nerthus, forma latinizzata del proto-germanico Nerthuz, con altre popolazioni germaniche stanziate lungo il basso corso dell'Elba, tra il Mare del Nord ed il Baltico, un ampio gruppo etnico a cui appartenevano anche Angli, Iuti e Sassoni. La figura femminile evoca il passaggio, una porta tra mondi differenti. Esemplare in questo senso il fregio sopra il portone di ingresso della Pieve di Corsignano a Pienza. Per via sincretica questi culti furono all'origine della devozione mariana nelle campagne toscane che si diffuse a partire dal IX secolo, rintracciabile ancora oggi nei cosiddetti Madonnini.
Il serpente.
I Longobardi riservavano un culto particolare per il serpente, ogni guerriero portava al collo un ciondolo d'oro con impressa la sua immagine (Goldene Schlange) ad esso veniva attribuito un significato protettivo e scaramantico. Anche se l'elite del popolo longobardo si convertì al cattolicesimo il grosso del popolo rimase fedele alle antiche tradizioni continuando ad adorare il serpente come ci spiega un testo del 1478: "Vite degli Imperadori e Pontefici Romani".
Difficile trovare tra i gioielli longobardi un esempio di questo ciondolo portafortuna, ma una medaglietta d'oro proveniente da una tomba sassone risalente al VI-VII secolo a Wingham nel Kent e conservata al British Museum, potrebbe essere un valido esempio vista la contiguità culturale tra i due popoli. Le spire dei serpenti intrecciandosi compongono il cosiddetto Nodo di San Giovanni, un simbolo tipicamente nordico.
L'adorazione dei Magi.
Un altro motivo ricorrente nell'arte sacra longobarda è l'adorazione dei Magi, in questi barbari persidi, sacerdoti zoroastriani, che venivano da oriente seguendo una stella i Longobardi riscoprivano in parte la loro epopea di popolo guidato alla loro terra promessa, l'Italia, e vedendo il culmine di questa migrazione la conversione al cattolicesimo. Così come i Magi (dalla radice proto-indoeuropea *magh- = abilità) i Longobardi erano in origine pagani, come i Magi erano indoeuropei, come i Magi venivano da oriente. L'oriente ha sempre avuto un grande signficato simbolico nella cultura di questo popolo.
I facion.
Nelle pievi romaniche spesso sono scolpite delle figure di facce, che troviamo a sinistra della porta nella già citata Pieve di Corsignano oppure dietro l'abside nella Pieve di Gaville. Questa abitudine di scolpire le facce sugli edifici o accanto agli stipiti delle porte con funzione apotropaica per scacciare gli spiriti maligni la ritroviamo molto diffusa anche in Lunigiana, nel pontremolese, nei cosiddetti facion.
Un vero campionario dei simboli tipici dell'arte longobarda lo troviamo nello splendido chiostro romanico di Torri.
Per un blog è molto importante il vostro sostegno, se potete cliccate sui tasti social "mi piace", "tweet" etc che trovate qui sotto ... grazie.
Facciamo qui una selezione dei principali temi che costituiscono un marker stilistico della presenza longobarda in Toscana, in modo che sia possibile per tutti avere la chiave di lettura per leggere queste antiche testimonianze.
Il vortex.
Il vortex è un simbolo molto antico sviluppatosi in molte civiltà indoeuropee, è centrale nella simbologia caucasica nel motivo iconografico della cosiddetta ruota armena dell'eternità. Simbolo solare per eccellenza rappresenta la forza generatrice della natura, ed il principio primo della vita.
Il vortex, la cui genesi è parallela a quella della svastica, un antichissimo simbolo di buon auspicio (sanscrito suasti-ka, portafortuna), è uno simboli della prima chiesa che vede l'Armenia come uno dei suoi centri propulsori a partire dal IV secolo. E' possibile che questa lastra conservata nell'antica Pieve di San Leolino presso Panzano in Chianti sia una testimonianza delle dottrine dell'arianesimo che venute da oriente ebbero un particolare successo tra i barbari convertiti tra cui Goti e Longobardi. In queste dottrine Dio è visto come principio generatore distinto dal Figlio che concepito dal divino ha però una sua natura umana. In pratica viene negata la trinità e la consustanzialità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'arianesimo, che prende il nome dal teologo Ario (256-336), fu condannato come eresia dal Concilio di Nicea nel 325.
Troviamo il motivo del vortex in alcune lastre in arenaria ad ornato depresso che nei templi proto-romanici costituivano il parapetto e quindi la divisione fisica tra il celebrante e la comunità dei fedeli. Queste lastre sono nella Pieve di San Leolino a Panzano nel Chianti fiorentino, una funge da supporto per l'altare, l'altra fa da decoro per il léggìo. La croce nella lastra inscrive un motivo celtico tipicamente nordico dell'arte vichinga che è il Nodo di San Giovanni. La lastra sotto l'altare è montata al contrario e quindi per poterla vedere correttamente occorre ruotare l'immagine di 180 gradi.
 |
| Pieve di San Leolino a Panzano |
 |
| Lastra ad ornato depresso - Pieve di San Leolino a Panzano Include dei vortex e al centro il nodo di San Giovanni |
 |
| Pietra dipinta di origine vichinga Isola di Gotland - Svezia |
 |
| Vortex, ruota dell'eternità detta anche ruota armena Lastra ad ornato depresso - Pieve di Corsignano a Pienza |
 |
| Ruota dell'eternità armena |
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente un simbolo ricorrente in tutte le architetture altomedievali di origine longobarda è il nodo di San Giovanni, San Giovanni fu oggetto di un partcolare culto da parte dei Longobardi in quanto rappresentava la ciclicità della vita che si identificava nel rito del battesimo. Si tratta di un antico simbolo magico protettivo scandinavo che ritroviamo anche in epoca vichinga ma che ha la sua origine in epoche assai più remote come nell'età del bronzo nordica. Il simbolo è utilizzato anche nel misticismo della Cabala.
Curiosamenente il nodo di San Giovanni detto anche St Hans's cross o St. John's Arms è il simbolo che Steve Jobs inserì nella tastiera del mac per identificare il command key e corrisponde al codice Unicode U+2318 ⌘
La stella a sei punte.
Altro simbolo assai ricorrente nell'iconografia longobarda è la stella a sei punte, detto anche "fiore della vita" o "stella-fiore", si tratta di una simbologia legata al culto del sole diffusa tra i paesi nordici ma anche in altre culture, panceltico e probabilmente legato ad un origine indoeuropea o indoaria. Le prime attestazioni di questo simbolo sono in ambito assiro e fenicio. Il fiore della vita, chiamato anche Sole delle Alpi e rosa celtica, si ritrova anche nel logo della Lega e della Padania.
La sirena bicaudata.
Questa raffigurazione evoca culti legati alla fertilità e ci riporta alla leggenda della Melusina (vedi post) ed al culto di Nerthus maturato soprattutto in ambito scandinavo e germanico. Secondo Tacito. I Longobardi condividevano il culto di Nerthus, forma latinizzata del proto-germanico Nerthuz, con altre popolazioni germaniche stanziate lungo il basso corso dell'Elba, tra il Mare del Nord ed il Baltico, un ampio gruppo etnico a cui appartenevano anche Angli, Iuti e Sassoni. La figura femminile evoca il passaggio, una porta tra mondi differenti. Esemplare in questo senso il fregio sopra il portone di ingresso della Pieve di Corsignano a Pienza. Per via sincretica questi culti furono all'origine della devozione mariana nelle campagne toscane che si diffuse a partire dal IX secolo, rintracciabile ancora oggi nei cosiddetti Madonnini.
 |
| Fregio sul portone di ingresso della Pieve di Corsignano a Pienza |
I Longobardi riservavano un culto particolare per il serpente, ogni guerriero portava al collo un ciondolo d'oro con impressa la sua immagine (Goldene Schlange) ad esso veniva attribuito un significato protettivo e scaramantico. Anche se l'elite del popolo longobardo si convertì al cattolicesimo il grosso del popolo rimase fedele alle antiche tradizioni continuando ad adorare il serpente come ci spiega un testo del 1478: "Vite degli Imperadori e Pontefici Romani".
"A Rotomio, loro rè, molti rè succederono: fra' quali Grimoaldo, & il suo figliuolo Romualdo, il quale a' Sanniti signoreggiava: al tempo del quale, avvengache e Longobardi fussino battezzati, nondimeno adoravano gl' idoli, & massime l'idolo del serpente"
 |
| Mensola con serpenti intrecciati Pieve di Santa Giulia a Caprona Credits: Francesco Fiumalbi |
 |
| Medaglietta sassone ritrovata a Wingham nel Kent Nodo di San Giovanni formato da intreccio di serpenti Credits: British Museum |
Un altro motivo ricorrente nell'arte sacra longobarda è l'adorazione dei Magi, in questi barbari persidi, sacerdoti zoroastriani, che venivano da oriente seguendo una stella i Longobardi riscoprivano in parte la loro epopea di popolo guidato alla loro terra promessa, l'Italia, e vedendo il culmine di questa migrazione la conversione al cattolicesimo. Così come i Magi (dalla radice proto-indoeuropea *magh- = abilità) i Longobardi erano in origine pagani, come i Magi erano indoeuropei, come i Magi venivano da oriente. L'oriente ha sempre avuto un grande signficato simbolico nella cultura di questo popolo.
I facion.
Nelle pievi romaniche spesso sono scolpite delle figure di facce, che troviamo a sinistra della porta nella già citata Pieve di Corsignano oppure dietro l'abside nella Pieve di Gaville. Questa abitudine di scolpire le facce sugli edifici o accanto agli stipiti delle porte con funzione apotropaica per scacciare gli spiriti maligni la ritroviamo molto diffusa anche in Lunigiana, nel pontremolese, nei cosiddetti facion.
 |
| Pieve di Gaville presso Figline Valdarno |
 |
| Pieve di Gaville presso Figline Valdarno Facion scolpito nella parte posteriore della Pieve |
Un vero campionario dei simboli tipici dell'arte longobarda lo troviamo nello splendido chiostro romanico di Torri.
Per un blog è molto importante il vostro sostegno, se potete cliccate sui tasti social "mi piace", "tweet" etc che trovate qui sotto ... grazie.


.JPG)


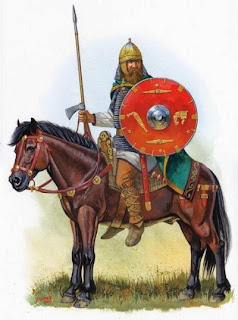
Per quanto riguarda l'interessante simbolismo proto-romanico caucasico del Vortex o ruota dell'eternità armena noto una notevole somiglianza con l'emblema della nazionale di rugby Georgiana ( in Georgiano borghali = croce rotante, a simboleggiare l'eternità della vita ) denominati i lelos di georgia o anche borghal-osnebi = portatori della croce rotante.
RispondiEliminahttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Georgie.svg
p.s. da oggi mi firmo cerdic se a te non dà fastidio. Buona sera!
Ci siamo scambiati info..noi per la lastra di San Leolino...e voi con il nostro video di Torri
RispondiEliminaGrazie e complimenti per il blog
Pievi Romaniche dellaToscana e Oltre
https://www.facebook.com/PieviRomanicheDellaToscanaEOltre
molto interessante
RispondiEliminaNel mio paese Levada di Onigo (tv)ho trovato 2 simboli Longobardi,il sole delle alpi e la ruota della vita di rara bellezza
RispondiElimina